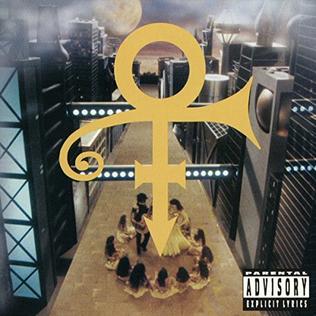i nile sono uno dei gruppi più unici e riconoscibili di tutto il death metal: sai esattamente cosa aspettarti da un loro disco. sono un gruppo che nasce da un’idea troppo precisa, troppo specifica per non essere perfettamente riconoscibile: fanno brutal death metal ispirato all’antico egitto, non puoi confonderli con nessun’altro. e c’è stato un momento, più o meno attorno all’uscita di questo disco, che sono diventati praticamente dei nuovi blind guardian: a tutti piacevano i nile, non potevano non starti simpatici i nile, c’era il death metal e indiana jones, cosa cazzo vuoi di più dalla vita?
risposta: non puoi avere di più dalla vita. nel caso poi di ‘in their darkened shrines’ davvero non puoi avere di più, alla sua uscita nel 2002 era il disco metal perfetto, veloce oltre ogni dire, tecnico e complesso ma atmosferico, brutale e violento ma a modo suo innocuo perché fiabesco e lontano, un mix perfetto di tradizione (morbid angel su tutti) e novità (strumentini stronzi, arrangiamenti curati e atmosferici, le mummie) in un pacchetto che non poteva essere più invitante con una copertina stupenda e i testi (con spiegazione allegata) ispirati agli orrori delle piramidi, alle torture immonde, ai misteri dell’egitto, su rieducational channel.
‘the blessed dead’ è una delle migliori aperture che si siano sentite in un disco metal, i suoni sono pazzeschi, la batteria suona naturale e pestata come fosse mr.sandoval in persona (anzi meglio, non me ne voglia commando), invece si chiama tony laureano ed è una bestia, le chitarre sono piene di sugna e sanno di cantina che manco una forma di taleggio nella tomba di tutankhamon, le voci sono un grugnito infernale ma quello che tira avanti tutta la baracca sono gli incredibili riff di karl anders, infinite colate dal suono unico che trascinano indietro di migliaia di anni. ‘sarcophagus’ presenta il lato lento e soffocante, il buio dentro la tomba, ornato di melodie paranoiche, avvolto in synth ambientali e appoggiato sui tappeti di doppia cassa supersonica di laureano.
tutto bellissimo, poi c’è ‘unas, slayer of the gods’. in poco meno di 12 minuti di canzone, i nile riassumono tutta la loro carriera, prendendo in prestito nel frattempo uno dei riff più belli del metal, quello di ‘well of souls’ dei candlemass, per rielaborarlo in veste brutal con effetto sfondamascella. poi il pezzo si inerpica per una struttura stronzissima con continui cambi, arrangiamenti di fiati, una parte atmosferica terrificante in mezzo e una continua epicità, un senso di meraviglia per orrori sopiti da secoli e secoli. e secoli.
un altro capolavoro è ‘i whisper in the ear of the dead’, un terrificante ibrido brutal/dark ambient su cui la voce cavernosa più che mai di sanders recita parole innominabili. non che il resto sia da meno eh, parliamo davvero di un capolavoro, un disco che ha preso le regole e l’estetica di un genere intero e li ha piegati ai propri voleri, utilizzandoli per creare un mondo in cui gli stessi nile sono rimasti intrappolati ormai da anni, proprio come i blind guardian citati prima hanno fatto con ‘nightfall in middle earth’, disco per molti versi simile a questo.
la suite finale è l’apoteosi del nero mondo fiabesco dei nile, 18 minuti in cui bordate brutal death accompagnano la narrazione alternati a oasi ambientali soffocanti e buie e un finale che più epico non si può, una tempesta di sabbia tra le rovine, dove le voci degli spiriti dei faraoni sussurrano nell’orecchio di chi si perde fra le dune. dai, sul serio, non si può non amare i nile.
il disco precedente, ‘black seeds of vengeance’, è figo quasi quanto questo e pure i due successivi, ‘annihilation of the wicked’ e ‘ithyphallic’, non sono un cazzo male. certo, bisogna sempre accettare il patto narrativo del gruppo: i nile parlano di egitto, sempre e comunque, le atmosfere sono quelle, i suoni pure. ‘ithyphallic’ gioca con qualche vena vagamente black ma sono sfumature, di fatto il suono del gruppo non si è evoluto e il loro immaginario è diventata una prigione. c’è da dire che quando sanders ha voluto fare un disco solista ha insistito su queste coordinate, pur eliminando il death metal e facendo un disco dark ambient suggestivo quanto usa e getta.
‘in their darkened shrines’ resta un miracolo, la prova di come il death metal sia materia malleabile e possa essere usato in maniera originale pur senza allontanarsi troppo dai suoi canoni, un sunto di un decennio abbondante del genere e una finestra sulle possibilità future, il tutto in un pacchetto originale e con carattere da vendere. tra i dischi da sentire assolutamente nella vita.